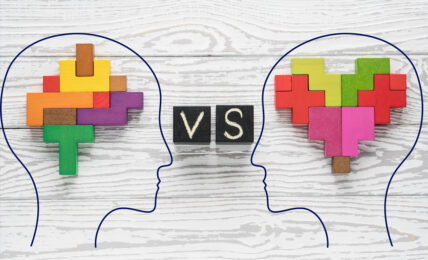Davide Grasso e la libertà che ancora non c’è
Dal crollo del Muro di Berlino c'è molto da imparare, specie per quanto riguarda l'impegno dei movimenti popolari che ne hanno consumato la solidità. Ne scrive il ricercatore che ha anche militato tra i foreign fighters contro l'Isis.