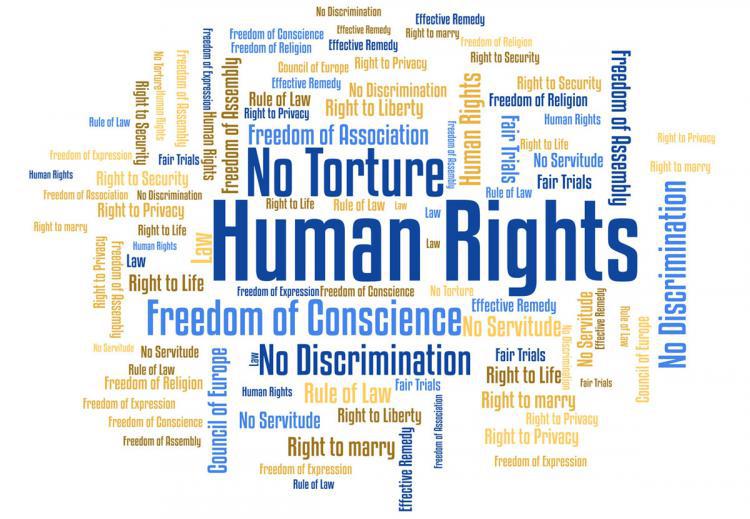Si fa presto a dire diritti umani…
Italia, Francia e Svezia si trovano in un momento storico in cui l'integrazione con altre culture determina un conflitto culturale sul concetto di diritti umani, parità di genere, identità di popolo. Altrove la Cina punta diritta all'assimilazione forzata degli Uiguri. Come fare per comprendere la complessità di questa situazione?