Thomas e la lotta contro il doping

La complessità di un fenomeno poco considerato
Thomas Zandonai è un ricercatore universitario di Rovereto (TN). Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Biomedicina Traslazionale presso il Laboratorio di Neuropsicofarmacologia dell’Università degli Studi di Verona, diretto dal professor Cristiano Chiamulera, si è trasferito in Spagna dove lavora presso il “Centro di ricerca, Mente, Cervello e Comportamento” dell’Università di Granada. Da qualche mese, collabora anche con il “Centro Ricerca sullo Sport” dell’Università Miguel Hernandez di Elche (Alicante). Il suo interesse di ricerca si focalizzata sul fenomeno doping. Thomas, studia come le sostanze – dopanti e non dopanti – possano avere un impatto sulla prestazione fisica e sui possibili rischi per la salute degli sportivi. Da parecchi anni, coordina e collabora a progetti educativi rivolti, principalmente, ai giovani. L’interesse per questo ambito di ricerca, nasce anche da una negativa esperienza personale, che ha spesso utilizzato per poter illustrare i meccanismi che portano un atleta a doparsi. «Quando racconto la mia storia, ho sempre il dubbio, visto che sono passati più di vent’anni, di essere anacronistico. Purtroppo, ci sono ai nostri giorni ancora atleti che vivono la mia stessa esperienza e, studiandone i processi, percepisco che nel mondo dello sport poco è cambiato» sottolinea Thomas.
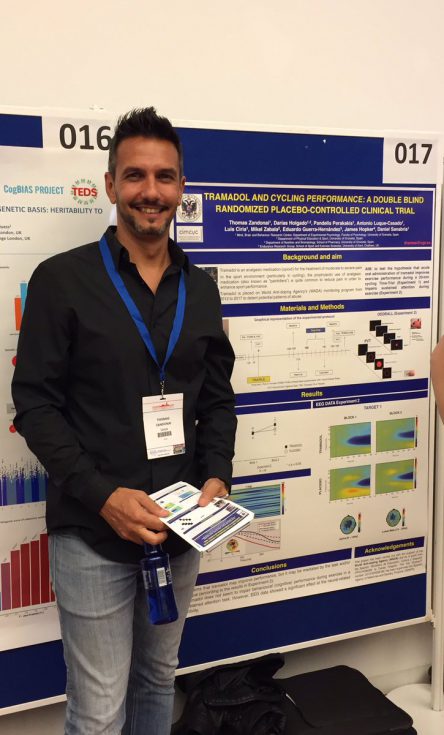
«Avevo otto anni quando salii sulla mia prima bici da corsa. Capii che per battere la fatica, l’unico modo era vincere. E così feci» spiega il ricercatore. «Dall’età di 13 anni ho iniziato ad allenarmi con corridori più grandi di me (di 17-18 anni) e ricordo perfettamente che il linguaggio che utilizzavano – pur non così esplicitamente chiaro per me – era incentrato sull’utilizzo di farmaci e tecniche per migliorare la prestazione. Era come percepirne l’odore senza vedere: una sorta di “profumo di doping”. Alcuni di questi ragazzi avevano già delle prestazioni che non potevano considerarsi “normali”. Grazie ai buoni risultati ottenuti entrai prima nel giro della Nazionale Juniores, poi nella Nazionale Militare. E proprio durante il militare che ho avuto la mia “iniziazione”».
Raccontaci cosa ti è successo…
«Lì ho visto le prime flebo, le prime iniezioni e numerosissime e diversificate scatole di farmaci. Ho cominciato a “toccare con mano” la realtà di quell’ambiente. Nessuno, però, mi propose l’utilizzo di sostanze illecite. Finito il periodo militare entrai in una squadra dilettantistica del Veneto. Il primo anno mi somministrarono farmaci descritti come integratori. Arrivai a farmi fino a un’iniezione al giorno. Negli anni successivi, grazie al mio lavoro, scoprii che mi avevano dato, per esempio, il Samyr, un potente antidepressivo, farmaco di cui non avevo assolutamente bisogno. Erano tutte sostanze che non mi avrebbero fatto risultare positivo ai controlli, ma che comunque – già a loro modo – rappresentavano un modo per educarti a un certo tipo di pratiche. Questo è uno dei messaggi subdoli che ancora oggi il mondo dello sport utilizza: “Ti senti stanco, i tuoi valori sanguigni sono bassi, devi curarti”. Ti trattano da malato quando non lo sei, ti controllano il peso in maniera ossessiva e ti sottopongo a pressioni ingiustificate: il tutto per poterti controllare. I dati che stiamo raccogliendo, ci dicono che stiamo assistendo a un aumento di uso di integratori alimentari in ambito sportivo. Alcuni studi dimostrano che chi è abituato ad assumerli ha maggiori probabilità di doparsi. Voglio precisare che non sto dicendo che gli integratori siano doping, sto solo illustrando un processo denominato “getaway”, dove aumenta, anche di 10 volte, tale probabilità. Tornando alla mia esperienza, durante il secondo anno in quella squadra – io avevo 21 anni – il direttore sportivo mi propose, su consiglio dell’allora medico sportivo Michele Ferrari (personaggio noto per aver seguito numerosi atleti coinvolti in fatti di doping tra i quali Lance Armstrong), di cominciare ad assumere la Eritropoietina, meglio conosciuta come EPO.»
Come te la prospettarono?
«Anche la modalità con cui ti “offrono” queste pratiche è parte di un meccanismo organizzato, lento, subdolo. Mi ricordo che appoggiarono la fiala sul tavolo e mi illustrarono i favolosi benefici che avrei avuto per la mia carriera. È l’atleta che deve fare il gesto di prendere, è una sorta di: “Vieni con noi, vincerai di sicuro!”. E l’atleta sa benissimo che se accetta comincia a far parte del sistema. Nell’arco degli anni ho visto personaggi, diventare ricchi e famosi grazie al doping e a fine carriera, solo a fine carriera, sparare a zero sul sistema. Troppo facile e poco credibile. Capisco, conoscendone le dinamiche, che non sia facile dire di no, però si tratta di scelte. Io rifiutai subito.»

Quali furono gli elementi che ti aiutarono a dire no?
«Questa è una delle domande che maggiormente mi fanno i ragazzi. Non è facile rispondere. Dire “sì” o “no” in questi contesti dipende da molteplici fattori. Io credo di aver avuto, oltre a una sana educazione etica in ambito familiare (mi sarei sentito troppo in colpa se avessi barato), la fortuna di incontrare, durante l’ultimo anno di carriera, un medico sportivo “personale” che mi ha informato sui possibili danni provocati dalle sostanze che mi davano. In una delle nostre telefonate mi illustrò chiaramente le conseguenze che avrei potuto avere se avessi assunto l’EPO: fu fondamentale per prendere quella decisione, anche se non fu facile.»
A cosa ti riferisci?
«Spesso chi fa sport ad alto livello, lo fa in maniera esclusiva. Difficilmente si riesce a coniugare, ad esempio, sport e studio. Le pressioni che spingono, sostengono e incoraggiano l’atleta arrivano da più ambiti: sociale, familiare, economico. Il piano B non esiste. Quindi, se decidi di non accettare determinate regole, sei fuori. Il mondo dello sport non è così diverso da altri contesti della vita. È migliorato negli anni, ma non possiamo dire che sia “sano”. Nel mio caso, come di altri sportivi che abbandonano ad alto livello, devi riscostruirti: piano piano. Ci vuole del tempo e come altri momenti nella vita passi attraverso più fasi come la delusione, la rabbia e lentamente arriva l’accettazione. Io decisi anche di denunciare ciò che mi era accaduto, sia per un senso di responsabilità verso i più giovani, sia per un senso di giustizia.»
Ci furono delle conseguenze?
«In uno di quei momenti di rabbia, scrissi la mia storia alla “Gazzetta dello Sport”. Ci fu allora l’interesse del Procuratore della sezione Antidoping di Roma e di Sandro Donati, la persona che più di tutte, in Italia, si è battuta (e si batte) contro il doping. A quei tempi, l’Italia non era dotata di una legge penale – arrivata solo nel 2000 con la Legge n. 376 – quindi le inchieste che si aprirono rimasero vincolate al mondo sportivo. Adesso ci sono, per fortuna, altri strumenti come il “WADA Whistleblowing Program”, un sistema di denuncia anonima, creato dalla World Anti-Doping Agency (WADA), che tutela maggiormente l’atleta.»
Che opinione ti sei fatto sul tema?
«È una tematica molto più complessa di quanto possa apparire. Gli atleti hanno il desiderio di superare i limiti sportivi e questo può portare all’utilizzo di sostanze proibite o non proibite per migliorare la loro performance. Spesso assistiamo a un “massacro mediatico” che si scatena ogni volta che qualcuno viene trovato positivo ai controlli. Senza assolutamente giustificare nessuno o assolvere a priori, sono tutti ragazzi e ragazze, uomini e donne che si fidano, spesso ciecamente, del loro entourage sportivo, familiare e medico. In qualche modo, deve essere così: la fiducia è importantissima, ma non può essere cieca. Tutti noi siamo sottoposti quotidianamente – e l’atleta non è da meno – a pressioni sociali, estetiche, economiche che faticosamente gestiamo, dove “la pillola miracolosa” sembra alleviarci, quando invece sappiamo che non è così. Porto come esempio due casi “estremi” che mi hanno colpito. Abbiamo visto, recentemente, la positività ai controlli da parte di un novantenne americano e di un quattordicenne italiano. Se nel primo caso possiamo essere assaliti da una sensazione di tristezza, nel secondo ci si deve interrogare sia sul “come” si è arrivati a questo e sul “chi” abbia procurato e iniettato uno steroide anabolizzante (Mesterolone) a un adolescente. Il ruolo del contesto sportivo – e familiare – deve essere considerato nella gestione di questo fenomeno, gestione che purtroppo è carente sia da un punto di vista informativo che educativo. Inoltre, il sistema antidoping in questo momento è fortemente criticato e messo in discussione. Per chi non fosse un esperto, è la World Anti-Doping Agency (WADA) che detta le linee guida, ha il compito di effettuare i controlli agli atleti e analizzare le provette (attraverso i vari laboratori sparsi nel mondo che devono essere accreditati dalla WADA stessa). Gli ultimi eventi (ad esempio il caso della Russia), hanno, ancora una volta, evidenziato come questa entità privata non sempre sia in grado di gestire questi scandali in maniera trasparente. Sempre più esperti suggeriscono che si debba creare un organo pubblico dotato di maggiore indipendenza sia dall’ambiente sportivo sia da quello politico. Da anni se ne discute anche in Italia, dove il Coni, l’ente pubblico a cui è demandata l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale che promuove la massima diffusione della pratica sportiva, si occupa allo stesso tempo dei controlli antidoping, agendo all’interno di un potenziale conflitto di interessi.»

Ma qualcosa di buono è stato pur fatto, nel recente passato…
«Assolutamente sì. C’è da dire che se va dato merito all’Italia di essere uno dei Paesi più impegnati e severi in questa lotta. Come accennavo precedentemente, in Italia nel 2000 è stata varata la Legge n. 376, una delle più severe a livello europeo in questo ambito che permette di intervenire anche in campo penale: si tratta di un passo decisivo per quel che riguarda le inchieste giudiziarie. Credo sia rilevante non vincolare il problema del doping solo alla frode e alla sanzione, importanti ma non unici aspetti. Per questo in Italia è presente la “Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive” che si occupa anche di promuove progetti di ricerca e campagne di informazione/formazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping. Al momento, le risorse maggiori vengono investite in ambito sanzionatorio e di controllo e per lo sport il doping – a livello di dati – non è un problema da risolvere.»
In che senso?
«La WADA ogni anno effettua nel mondo circa 350.000 controlli antidoping attraverso le NADO (Agenzie Antidoping Nazionali). La percentuale di atleti positivi oscilla tra il 1,5% e il 2%. Uno degli strumenti efficaci messi in atto negli ultimi anni è il passaporto biologico, un monitoraggio nel tempo di alcuni parametri – “biomarcatori di doping” – che rivelano indirettamente l’effetto che una sostanza vietata per doping induce sull’organismo. Qui, secondo la letteratura, il dato percentuale di valori anomali si aggira attorno al 14%: più efficace lo strumento, più alto il dato percentuale. Stiamo parlando soltanto di dati relativi all’ambiente agonistico e professionistico. È interessante notare che la percezione del fenomeno da parte del grande pubblico è molto maggiore del dato reale a dimostrazione della difficoltà nel trasmettere informazioni corrette.»
In che modo si fa prevenzione?
«Per capire come agire bisogna innanzitutto analizzare a fondo il problema. Cosa non semplice, visti i numerosi fattori, medico-farmacologici, etici e psicosociali, implicati in questo processo. Di prevenzione non se ne fa molta. Sia l’ambito sportivo sia quello di salute pubblica non hanno piani strutturali finalizzati per intervenire concretamente. La ricerca scientifica diventa fondamentale e come sappiamo i fondi in Italia non sono molti. Solo recentemente si sta dimostrando la validità, o meno, che può avere un progetto rispetto ad un altro. Grazie a questi dati si potranno apportare le modifiche necessarie per essere realmente incisivi creando così dei protocolli di intervento utili (ad esempio in ambito scolastico). Inoltre, i dati sulle conoscenze e i comportamenti in ambito doping, non sono di certo incoraggianti. Non mi sto riferendo al grande pubblico, ma proprio a coloro che fanno parte del mondo sportivo: atleti, dirigenti, medici. Anche gli studenti universitari non si sottraggono a questa critica, anzi mostrano delle lacune importanti indipendentemente dai corsi universitari frequentati. Inoltre, si devono considerare – quindi studiare – le nuove forme comunicative attraverso le reti sociali e internet. Quest’ultimo utilizzato sia per rifornirsi di sostanze proibite sia per insinuare messaggi “fake” alimentando così ancora di più la confusione a scapito della protezione della salute.»

Quali sono i rischi per chi pratica il doping?
«Considerando la complessità del problema, si può dire che i rischi sono di varia natura. Se parliamo dell’abuso delle sostanze, dipende da fattori come, ad esempio, la dose e la tolleranza da parte del soggetto. Cercando di semplificare, possiamo dire che, l’utilizzo di steroidi anabolizzanti (per aumentare la forza) – non giustificato da condizioni mediche e ad alte dosi – può creare ipertrofia cardiaca, aumentare l’aggressività, indurre ginecomastia e infertilità negli uomini così come mascolinizzazione tra le donne. Se invece pensiamo all’EPO che, utilizzata negli sport di resistenza, aumenta il numero di globuli rossi, può portare a fenomeni trombotici o problemi renali, sempre tenendo in considerazione un uso non controllato medicalmente. Negli ultimi anni stiamo assistendo a un aumento dell’utilizzo di antidolorifici nell’ambiente sportivo. Il dolore e la stanchezza sono una sensazione spiacevole che, nello sport, può essere un fattore limitante per raggiungere un’ottimale prestazione. È interessante notare che la ricerca basata sull’evidenza non ha dimostrato chiaramente l’efficacia nelle prestazioni però suggerisce che questi farmaci possono avere effetti collaterali importanti, compresa la diminuzione della vigilanza, le convulsioni e che possano dare dipendenza. La ricerca scientifica diventa fondamentale al fine di proteggere la salute dello sportivo, agonista o amatoriale che sia, il quale può correre dei rischi utilizzando sostanze sconosciute, o tentando pratiche pericolose non sapendo che tipo di reazione può avere il suo corpo. La ricerca, la formazione e gli atti sanzionatori da soli valgono poco se non sono supportati da piani strategici di intervento che solo le scelte politiche adeguate possono mettere in atto. E qui mi fermo per non incorrere in possibili querele.»
