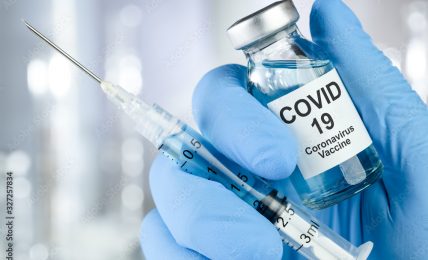Due storie d’Europa. Una possibilità per il futuro
Ci sono momenti della storia in cui l’Europa ha saputo immaginare mondi nuovi. E altri in cui, incapace di darsi una narrazione comune, ha smesso di esistere come progetto politico. Tra i casi più istruttivi ci sono due esperimenti quasi coevi: la Confederazione polacco-lituana e le Province Unite olandesi. L'articolo di Marco Spazzini del Movimento Federalista Europeo della Valpolicella.