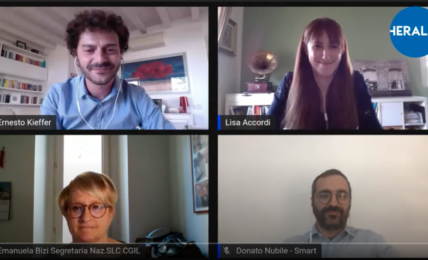In dialogo con il mondo: la Biennale tra intelligenza, adattamento e riparazione
Alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura, Carlo Ratti guida un’edizione che trasforma Venezia in un laboratorio globale. Tra utopia, tecnologia e responsabilità sociale, l’architettura si fa collettiva, critica e lungimirante.