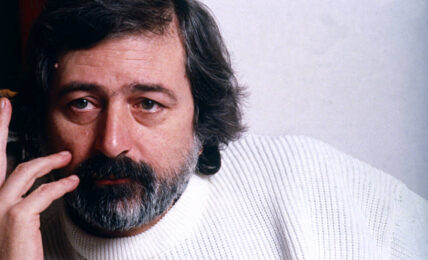Scipione Maffei, il veronese che guardava lontano
Sabato 25 ottobre 2025, alle 9.30, nella sala convegni del Palazzo della Gran Guardia a Verona, si terrà l’incontro dal titolo “La sconfitta di una buona causa. Scipione Maffei tra economia, finanza e teologia”, evento inserito nella seconda edizione di RelazionEXPO – Fiera delle Relazioni