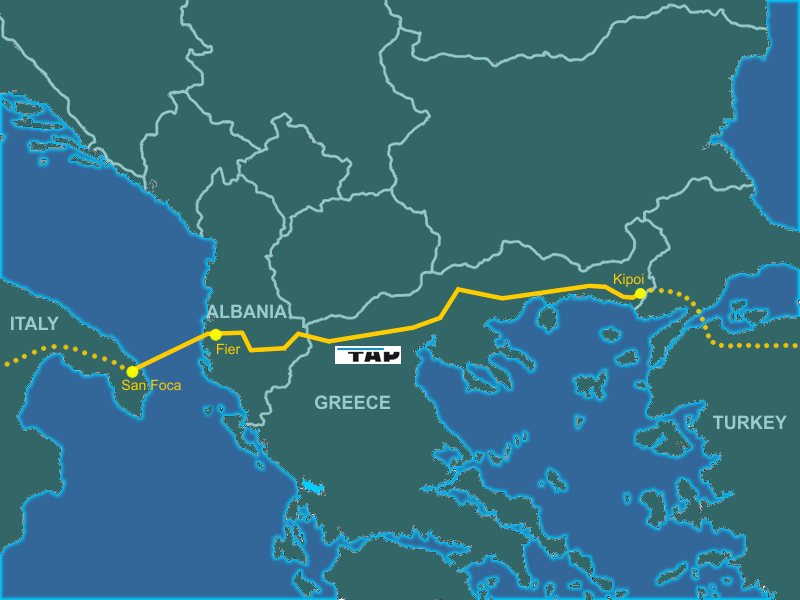Caucaso, le ragioni di un conflitto
Armenia e Azerbaijan hanno ripreso il loro conflitto, che dura ormai da quasi trent'anni. Ragioni economiche e interessi di molte potenze militari (Turchia e Iran su tutte) condizionano i negoziati di pace. E l'Italia...