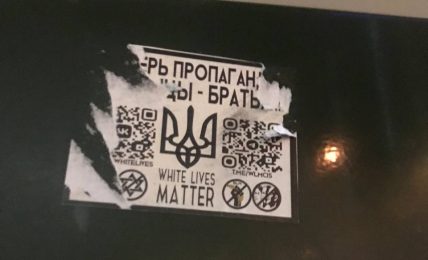Sistemi fragili, mondi instabili: la responsabilità umana tra clima, AI e vita
Al Pianeta Festival di Lucca, Stefano Mancuso ha guidato il pubblico attraverso la complessità dei sistemi naturali e sociali, tra instabilità dei corpi celesti, cambiamenti climatici, buco dell’ozono e sfide dell’intelligenza artificiale, invitando a riflettere su scelte, responsabilità e futuro del pianeta.