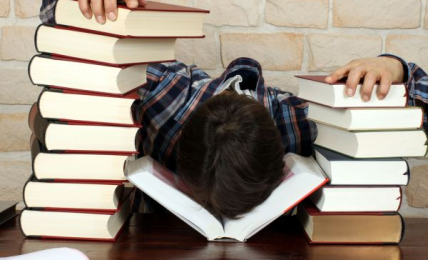Psicologo scolastico ed educazione emotiva: verso un paradigma educativo centrato sul benessere
L’introduzione strutturata della figura dello psicologo scolastico e l’integrazione dell’educazione emotiva nei curricula scolastici sono due proposte che intendono promuovere il benessere psichico, relazionale e sociale degli studenti.