Ringraziando la democrazia, ma andando oltre

Parafrasando il paradosso del mentitore: se un cretese affermasse che tutti i cretesi sono sempre bugiardi, mentirebbe o direbbe il vero? Questione apparentemente oziosa. Ma riportiamo questo paradosso alla realtà di Veronetta nel dicembre del 2018, con lo sconquasso creato dalla presenza di forze di estrema destra di ispirazione fascista: con un voto regolare e democratico, se i cittadini di uno Stato decidessero di eleggere un governo che nel suo programma proponesse l’abolizione della democrazia, potrebbe la democrazia accettarlo?
Cos’è la democrazia. «Forma di governo in cui il potere risiede nel popolo, che esercita la sua sovranità attraverso istituti politici diversi; forma di governo che si basa sulla sovranità popolare esercitata per mezzo di rappresentanze elettive, e che garantisce a ogni cittadino la partecipazione, su base di uguaglianza, all’esercizio del potere pubblico» dice una definizione di democrazia: un sistema che connota i Paesi occidentali e che, sull’onda del declinante impero americano, si è cercato di esportare nei paesi sotto la sua sfera d’influenza.
Il modello americano. Ed è appunto l’America il modello di riferimento per la democrazia moderna: diritto assoluto di stampa che si esprime in un controllo ossessivo del potere anche per questioni morali (come lo scandalo Clinton, ad esempio), senso del dovere civico, uguaglianza formale.
Di fatto, se i motori sociali dell’essere umano si sviluppano su due aspetti, il desiderio di far parte di qualcosa (il gruppo) e il desiderio di emergere come individuo, non possiamo non notare che questo sistema penalizza fortemente una di queste due istanze. Se il tallone d’Achille delle democrazie popolari sovietiche era l’uguaglianza sostanziale, imposta fin dagli esordi della Rivoluzione con la cancellazione di coloro che non intendevano adeguarsi a un ideale che cancellava la libera iniziativa e l’ideale borghese (come, ad esempio, i Kulaki, la prima classe di contadini imprenditori della Russia zarista), per quelle occidentali è l’individualismo spinto ed egoistico il vero limite: nella vita e, quindi, nella politica. E sin dai tempi dello stoicismo, dell’epicureismo e del circolo scipionico, l’individualismo è nemico della partecipazione alla vita della Polis. Fatta eccezione per la sfida Clinton-Trump, la percentuale dei votanti alle elezioni negli U.S.A. è sempre piuttosto ridotta. Non va meglio in Italia, dove la percentuale dei votanti è costantemente in calo.
Il malessere della democrazia. Questo sistema, è tuttavia evidente, soffre del male di tutti i sistemi di gestione della convivenza tra esseri umani: sopravvive finché la spinta, le motivazioni sociali e la coscienza del popolo che li ha prodotti vibra. È questa una lettura della storia alla Giambattista Vico, che vedeva nella Repubblica di Platone il punto di arrivo di un percorso evoluzionista dell’umanità, che nella vulgata corrente propone il sistema democratico come il migliore dei sistemi possibili. Ma l’evoluzionismo storico è oramai un rottame ottocentesco: il bianco europeo non regge più la fiaccola della civiltà e persino la sbronza entusiastica postbellica nata con la fine dei totalitarismi sembra aver perso il suo effetto. I motivi sono molteplici. Alcuni, in ordine sparso:
Il conflitto è dunque intricato e su più livelli. A livello globale almeno 3 potenze (U.S.A., Cina e Russia: la Francia è un “vorrei ma non posso”) decidono gli equilibri e, anche se in competizione, convergono nella necessità di controllare i cittadini limitandone la privacy di diritto e di fatto, restringendo la libertà di movimento e di pensiero. Lasciando perdere la Cina, che dopo il bavaglio alla rete sta persino progettando bagni pubblici con telecamere a riconoscimento facciale e a impronta digitale, anche gli Stati Uniti, paladini della libertà e del diritto di parola, da anni emanano leggi restrittive, dalla legge Smith (1940) all’ordine esecutivo Truman (1947), dall’Internal Security Act del 1950 fino al Patriot Act del 2001. L’Italia, durante la guerra fredda, mai avrebbe potuto eleggere un governo di sinistra e, quindi, è sempre stata priva di effettiva autonomia: la libertà dei servi, insomma, che si misura anche nella distanza tra le istanze costituzionali e la prassi governativa, tra diritto formale e sostanziale dell’individuo. La democrazia, quindi, non garantisce necessariamente la libertà all’individuo.
Oltre a questo, poteri esterni e sovranazionali interferiscono con le decisioni nazionali. Qualche anno fa la questione dei derivati riempiva le prime pagine e svuotava le casse dello Stato italiano con una polizza assicurativa bizzarra, che affidava a multinazionali come Morgan Stanley il ruolo di scudo contro le turbolenze dei mercati finanziari che minavano la stabilità dell’Italia. Turbolenze – o, meglio, tempeste – provocate, per inciso, dalle stesse banche. Il gioco delle tre carte, insomma: obiettivi il guadagno tout court e costringere l’Italia ad adottare riforme gradite ai mercati ma non agli italiani (la riforma detta Fornero, ad esempio). È una realtà sotto gli occhi di tutti che società finanziarie con disponibilità economiche superiori al PIL di molti stati avanzati, in accordo o in parallelo con le tre potenze, perseguano strategie indipendenti o in contrasto con le decisioni legittimamente prese dalle democrazie nazionali, condizionando i rappresentati dei governi con finanziamenti leciti (o illeciti) e spostando la sovranità dalla volontà dei cittadini all’interesse degli azionisti. In questo intrecciarsi di esigenze politico-militari internazionali e locali, di esigenze di entità economiche esterne ai governi nazionali (ma paradossalmente finanziate dai risparmi dei cittadini di molti di quegli stessi Stati, che potrebbero votare in un senso e comprare azioni di una multinazionale che agisce in senso opposto, magari senza saperlo) la voce del singolo individuo nel rivendicare la propria parte di sovranità è forzatamente destinata a perdersi.
Ecco dunque il male oscuro che rode la nostra democrazia: un contenitore privo di contenuti, che nella disaffezione e nel disimpegno lascia spazio a forze che democratiche non sono, è destino a smarrire la propria funzione. Ed ecco come in coloro che ancora si ostinano a cercare una quadra tra l’interesse collettivo e quello individuale la democrazia non è più un dogma.
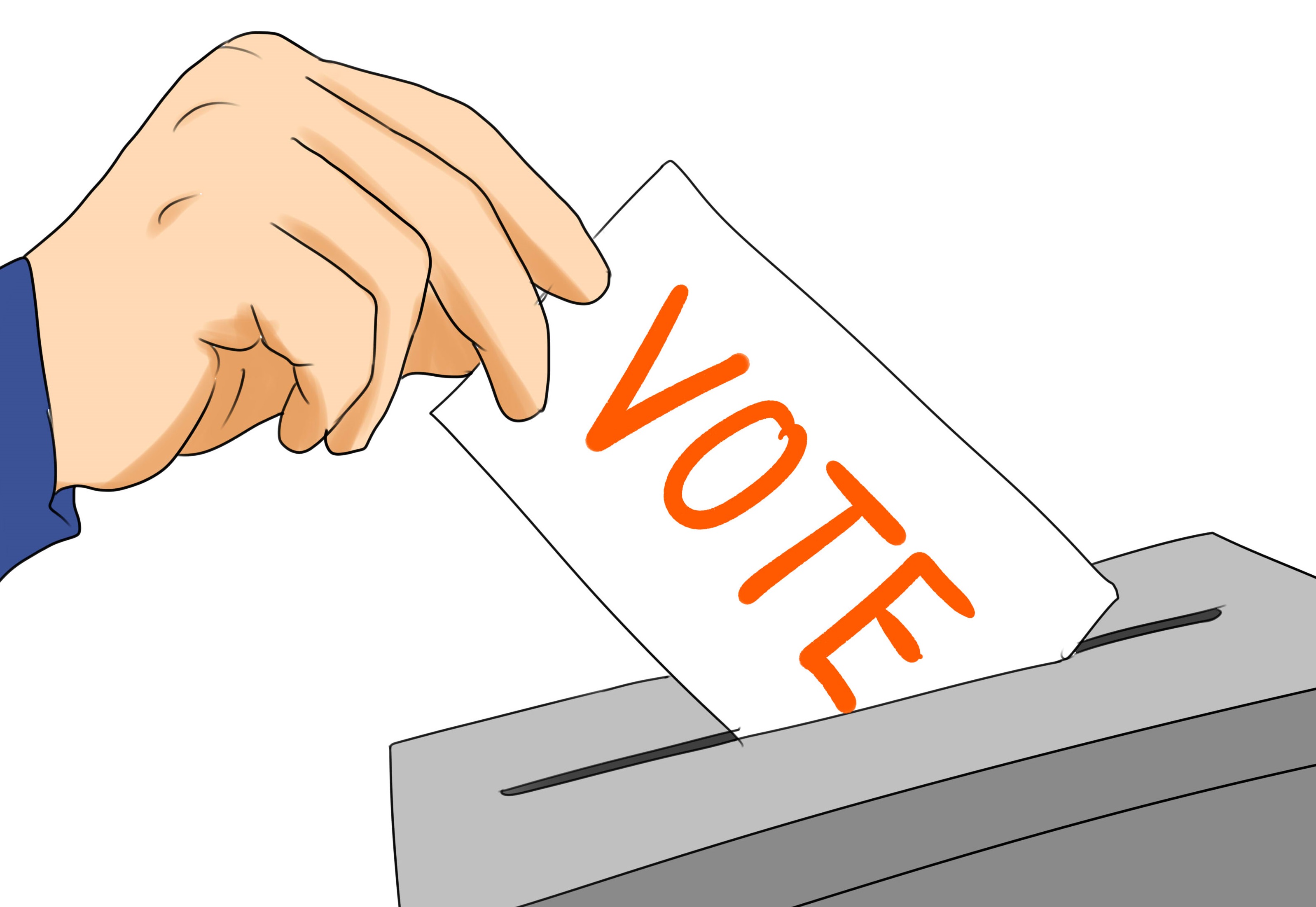 Pars construens. «È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora» disse Churchill alla Camera dei Comuni nel novembre 1947: forse è invece ora di pensare a qualcosa di nuovo, che affronti il problema maggiore, ovvero la disaffezione. Forse è ora di sperimentare qualcos’altro, sfruttando strumenti tecnici e comunicativi impensabili per il passato, superando una apparente democrazia come l’attuale e puntando a una gestione del potere a piccoli gruppi e in territori circoscritti, con un’identità forte. Un modello attivo, nel quale chi non sia interessato ad esercitare il proprio potere ne venga sollevato.
Pars construens. «È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora» disse Churchill alla Camera dei Comuni nel novembre 1947: forse è invece ora di pensare a qualcosa di nuovo, che affronti il problema maggiore, ovvero la disaffezione. Forse è ora di sperimentare qualcos’altro, sfruttando strumenti tecnici e comunicativi impensabili per il passato, superando una apparente democrazia come l’attuale e puntando a una gestione del potere a piccoli gruppi e in territori circoscritti, con un’identità forte. Un modello attivo, nel quale chi non sia interessato ad esercitare il proprio potere ne venga sollevato.
Forse è ora di stabilire collettivamente una idea di società, un obiettivo condiviso e la possibilità di distinguersi nella realizzazione di quell’obiettivo.
«‘l pastor che procede,
rugumar può, ma non ha l’unghie fesse»
scrisse Dante nel canto XVI del Purgatorio e lo ribadì nel III libro del De Monarchia. L’Alighieri tentò, con la teoria dei due soli, di armonizzare il potere temporale con quello spirituale. Questi due poteri oggi sono, ieri come oggi, l’interesse collettivo di specie e il diritto alla felicità individuale. Si apre quindi la necessità di un potere generale, Dante direbbe universale, che limiti le ingerenze e le distorsioni del mercato internazionale per permettere, al contempo, all’individuo di realizzarsi come persona e di sentirsi parte di una comunità detentrice di un potere effettivo su di sé.
Forse è giunto il momento di considerare l’idea che molti dei dogmi che ci siamo costruiti e che ci definiscono come società vengano ridiscussi e superati, anche quelli che oggi sembrano irrinunciabili, per aprire una fase nuova.
