Referendum 8-9 giugno: “Facciamo un po’ di chiarezza”
L'intervista a Laura Parotto, avvocata del lavoro e tesoriera di Verona Radicale, sui quattro quesiti referendari dedicati al tema del lavoro.

L'intervista a Laura Parotto, avvocata del lavoro e tesoriera di Verona Radicale, sui quattro quesiti referendari dedicati al tema del lavoro.

L’8 e il 9 giugno saremo chiamati a esprimerci su cinque referendum abrogativi. Oltre al Referendum cittadinanza, quattro quesiti – promossi dalla CGIL che, per presentarli, ha raccolto più quattro milioni di firme – sono in materia di lavoro. Si tratta di quesiti molto tecnici, che hanno come obiettivo principale quello di abrogare uno dei decreti legislativi del Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro introdotta tra il 2014 e il 2016 dal Governo di Matteo Renzi. Per conoscere i contenuti di questi quattro referendum, e anche per capire quali sarebbero, in concreto, gli effetti in caso di vittoria del “Sì”, abbiamo intervistato Laura Parotto, avvocata del lavoro e tesoriera di Verona Radicale.
Avvocata Parotto, dei quattro quesiti, il più pubblicizzato dalla CGIL è quello sul Jobs Act.
«Premetto che quando si affronta il tema delle tutele in caso di licenziamento illegittimo si tende a parlare solo della tutela più forte, che prevede la reintegra per i casi più gravi e indennità risarcitorie, anche cospicue, per i casi meno gravi. Questo può indurre a pensare che tale tutela si applichi a tutti. In realtà non tutti i lavoratori beneficiano di questo tipo di tutela ma soltanto i dipendenti da aziende “grandi”, ossia da aziende che occupano più di quindici dipendenti nella sede aziendale o nel comune in cui ha luogo il licenziamento oppure che occupano complessivamente più di sessanta dipendenti. Per i lavoratori dipendenti da aziende piccole (fino a quindici dipendenti) non è prevista la reintegra (salvi i casi gravissimi di licenziamento nullo perché discriminatorio, ritorsivo, comminato in concomitanza col matrimonio, in violazione di divieti, in forma verbale ecc.), ma soltanto una tutela indennitaria.»
In tema di licenziamenti illegittimi, cosa prevede oggi la normativa?

«Attualmente coesistono due discipline di tutela in caso di licenziamento illegittimo. Ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, si applica, se dipendenti di aziende “grandi”, l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla Legge n. 92/2012, meglio conosciuta come Legge Fornero; in caso di dipendenti di aziende piccole, invece, si applica la Legge n. 604/1966. Ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2025, invece, si applica il Decreto legislativo n. 23/2015, uno dei decreti del Jobs Act.»
E cosa chiede il quesito referendario?
«Il quesito propone di abrogare proprio il Decreto legislativo n. 23/2015. Se il referendum passasse, si tornerebbe, quindi, all’applicazione anche ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (se dipendenti da “grandi” aziende) o della Legge n. 604/1966 (se dipendenti da piccole aziende). Invece, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 non cambierebbe nulla.»
Quindi, secondo la CGIL, col referendum si tornerebbe al reintegro del lavoratore licenziato ingiustamente dalle grandi aziende.
«In realtà, anche il Jobs Act, già dalla sua emanazione, prevede la tutela reintegratoria piena per i licenziamenti nulli (discriminatorio, ritorsivo, comminato in concomitanza col matrimonio, in violazione di divieti, in forma verbale, e via dicendo), nonché la tutela reintegratoria attenuata per i casi di insussistenza della giusta causa e – a seguito di una sentenza della Corte costituzionale – di giustificato motivo oggettivo. Per i casi meno gravi, la tutela è solo indennitaria e compresa tra le sei e le trentasei mensilità. Il Jobs Act ha poi subito varie modifiche, sia ad opera della Corte costituzionale sia tramite il cosiddetto Decreto Dignità, per cui è sicuramente diverso dal Jobs Act originario. Ma mi preme sottolineare come anche il Jobs Act veda la coesistenza, per i licenziamenti illegittimi, tra le tutela della reintegra del lavoratore e la tutela solo indennitaria. In un quadro normativo così complesso, per capire la reale portata del quesito referendario, occorre poi un’altra precisazione sulla normativa a cui si tornerebbe se vincesse il “Sì”.»
Ci spieghi meglio.
«È vero che, se vincesse il “Sì”, si tornerebbe all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ma va detto che non sarebbe l’articolo 18 originario, bensì l’articolo 18 come modificato dalla Legge Fornero nel 2012. E, come per il Jobs Act, anche l’articolo 18 attualmente prevede un’articolata gradazione di tutele diverse a seconda della gravità del vizio del licenziamento. La tutela reintegratoria piena (ossia quella che l’articolo 18 prevedeva fin dalle origini) è prevista solo per i licenziamenti più odiosi (discriminatorio, ritorsivo, in violazione di divieti, verbale e via dicendo); nei casi di insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo, ha invece luogo la tutela reintegratoria cosiddetta “attenuata”, che vede la compresenza della reintegrazione e di un risarcimento fino a un massimo di dodici mensilità; negli altri casi meno gravi di illegittimità, il lavoratore può ambire a una tutela meramente indennitaria compresa tra dodici e ventiquattro mensilità.»
E quindi?
«In sostanza, il Jobs Act che si vorrebbe abrogare, e la disciplina a cui si tornerebbe (e che già si applica ai licenziamenti di lavoratori assunti nelle aziende “grandi” prima del 7 marzo 2015), non sono più tanto diverse per quanto riguarda la tutela reintegratoria e prevedono due diversi range per la tutela indennitaria. Sicché, al lavoratore cui si applichi la tutela indennitaria può convenire il Jobs Act se ha una anzianità aziendale elevata, o l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori se ha una anzianità aziendale breve. In sostanza ci sarebbe una uniformazione della disciplina applicabile a tutti i lavoratori (indipendentemente dalla data di assunzione), ma non certo una “rivoluzione” in tema di tutela reintegratoria.»

Il secondo quesito chiede di eliminare il tetto massimo di sei mensilità di indennità prevista per i lavoratori licenziati illegittimamente dalle piccole aziende.
«Questo quesito è strettamente legato a quello precedente in quanto presuppone appunto l’abrogazione del Jobs Act e, quindi, il ritorno per tutti i lavoratori alla disciplina previgente. Per i dipendenti da aziende piccole, in caso di licenziamento illegittimo il Jobs Act prevede una tutela indennitaria compresa tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità. Se col quesito precedente si abrogasse il Jobs Act, si applicherebbe a tutti i lavoratori delle piccole aziende la Legge n. 604/1966 che prevede un’indennitaria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità. Il secondo quesito vuole abrogare il tetto massimo di sei mensilità previsto dalla Legge n. 604/1966.»
Quali effetti avremmo in caso di vittoria del “Sì”?
«L’abrogazione del tetto massimo di sei mensilità significa che in casi di licenziamento illegittimo il giudice potrà riconoscere al lavoratore un’indennità anche superiore alle sei mensilità in base ai parametri previsti dalla legge quali il numero dei dipendenti, la dimensione dell’impresa, l’anzianità di servizio del lavoratore, il comportamento e le condizioni delle parti. Questo consentirà ai lavoratori delle piccole imprese di aspirare, specie se con una anzianità di servizio elevata, di ottenere un’indennità superiore a quella che è possibile ottenere oggi. Dall’altro lato, però, probabilmente assisteremo di pari passo a un aumento del contenzioso giudiziale.»
Il terzo quesito riguarda sempre il Jobs Act e propone di abrogare alcune delle regole sui contratti a termine.
«Anche in questo caso va sottolineato che l’attuale disciplina del contratto a termine, pur essendo contenuta all’interno di uno dei Decreti legislativi di cui si compone la riforma Jobs Act (il D. Lgs. 81/2015), ha subito varie modifiche. Questo perché il contratto a termine è diventato il “simbolo” della precarietà, per cui ogni Governo si sente in dovere di apportare delle modifiche.»
Com’è cambiata la disciplina?
«Prima del 2012 tutti i contratti a termine dovevano contenere la causale, ossia l’indicazione della motivazione organizzativa, produttiva o sostituiva per la quale il lavoratore veniva assunto a termine. In assenza di causale (sia perché scritta male, sia perché non corrispondente alla realtà) il contratto si considera a tempo indeterminato e il lavoratore, alla scadenza, può agire in giudizio per ottenere il ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno. Ciò ha causato in passato un notevole contenzioso giudiziale. Nel 2012 la Legge Fornero, per incentivare le assunzioni anche a termine, ha introdotto la possibilità di assumere un lavoratore a termine senza causale per un massimo di dodici mesi. Il Jobs Act, nella sua versione originaria, ha liberalizzato ulteriormente il contratto a termine prevedendo la possibilità per le aziende di assumere un lavoratore a termine senza causale per un massimo di trentasei mesi. Nel 2018 il Decreto Dignità ha riportato la possibilità di usare un contratto a termine senza causale fino a un massimo di dodici mesi, e ha ridotto da trentasei a ventiquattro mesi il periodo massimo di contratti a termine tra le stesse parti. Per stipulare contratti a termine oltre i dodici mesi (e fino ai 24 concessi), le aziende avrebbero dovuto inserire una causale tra quelle previste dal Decreto, peraltro di difficile comprensione.»
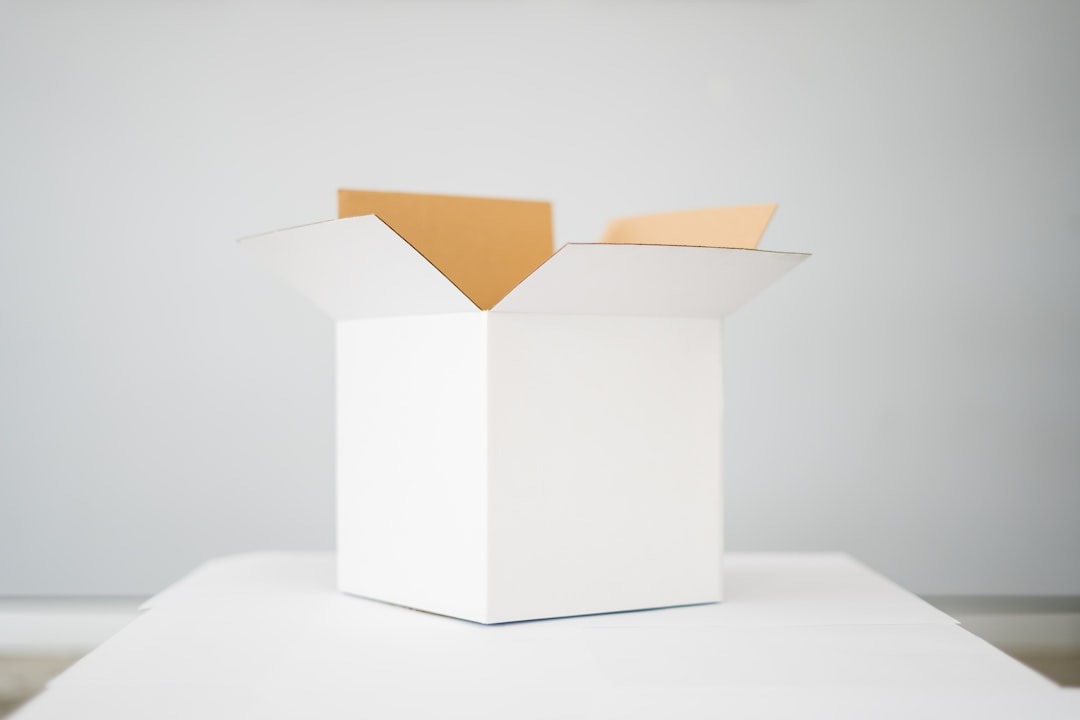
Quali effetti hanno comportato queste modifiche?
«L’effetto principale è stato quello di indurre le aziende a decidere, al termine dei dodici mesi, se confermare il lavoratore a tempo indeterminato o se lasciar scadere il contratto. Le causali, in sostanza, non mi risulta siano state utilizzate.»
Anche il Governo Meloni è intervenuto sulle causali?
«L’attuale Governo ha eliminato la descrizione delle causali contenuta nel Decreto Dignità, e ha rinviato alla contrattazione collettiva per l’individuazione delle causali apponibili dopo i dodici mesi. Ad oggi, quindi, il periodo massimo senza causali del contratto a termine rimane a dodici mesi.»
Cosa chiede il quesito referendario?
«L’obiettivo del referendum è quello di eliminare il periodo massimo senza causali del contratto a termine e di tornare al passato. Se vincesse il “Sì”, quindi, tutti i contratti a termine dovranno contenere la causale. In assenza di quest’ultima, formale o sostanziale, il lavoratore potrà agire in giudizio affinché il contratto sia accertato come indeterminato e siano disposti il ripristino dello stesso e il risarcimento del danno. Il vero interrogativo è come potrebbero reagire le imprese: ridurranno effettivamente il ricorso al contratto a termine, o torneranno ad aumentare le cause in tribunale?»
E sarebbe un bene o un male, nella pratica?

«Non so come reagirebbero le aziende a questa modifica. Sicuramente, se continueranno a usare il contratto a termine, un effetto sarà l’aumento delle cause nei tribunali, con tutte le conseguenze che ne derivano. C’è da dire che, se un contratto genera un eccesso di contenzioso, forse significa che non è uno strumento utile.
Mi chiedo quindi se abbia senso reintrodurlo. Mi permetto inoltre di segnalare che il Jobs Act, se da un lato ha liberalizzato il contratto a termine, dall’altro ha abrogato il contratto a progetto. Entrambi i contratti hanno una scadenza, con la differenza che col primo il lavoratore gode dello stesso trattamento normativo, retributivo e contributivo di un lavoratore a tempo indeterminato, mentre lo stesso non si poteva dire del contratto a progetto. Forse il Jobs Act ha fatto anche cose buone.»
Il quarto quesito vuole estendere la responsabilità dell’imprenditore committente in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali occorsi a dipendenti dell’appaltatore.
«Si fa riferimento al caso in cui un’azienda committente affidi in appalto ad un’altra azienda, il cosiddetto appaltatore, la realizzazione di un’opera o di un servizio all’interno della propria sede o unità produttiva. Il testo unico in materia di sicurezza, il Decreto legislativo n. 81/2008, già prevede che, nel caso di infortunio o di malattia professionale occorsi a un dipendente dell’appaltatore, sia quest’ultimo che il committente siano responsabili in solido. Questo significa che il lavoratore può chiedere all’uno o all’altro il risarcimento del danno subito nella parte non indennizzata dall’Inail. Attualmente ciò avviene con la sola eccezione del caso in cui l’infortunio o la malattia professionale del lavoratore in appalto sia conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività dell’azienda appaltatrice, ossia di rischi che fuoriescono dalla sfera di controllo del committente.»
Cosa chiede il referendum?
«L’obiettivo del quarto quesito è di abrogare questa eccezione, affinché il committente sia sempre responsabile assieme all’appaltatore di tutti i danni derivanti al lavoratore a causa di infortunio o malattia professionale. Questo potrebbe responsabilizzare maggiormente i committenti nella scelta degli appaltatori cui affidare attività in appalto da eseguire all’interno della propria azienda, privilegiando i soggetti affidabili, anche se ad un costo maggiore.»
Sul sito del comitato promotore, i quattro referendum vengono presentati con titoli importanti: “Stop ai licenziamenti illegittimi”, “Più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese”, “Riduzione del lavoro precario”, “Più sicurezza sul lavoro”. A livello giuridico, come valuta la portata di questi referendum dal punto di vista della tutela di lavoratori e lavoratrici?
«Comprendo la necessita di utilizzare slogan in una campagna referendaria; tuttavia, da un punto di vista giuridico, non ritengo che l’abrogazione del Jobs Act produrrebbe l’effetto sperato di ridurre drasticamente il numero dei licenziamenti, che si comminavano anche quando era in vigore l’originario articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, prima che venisse modificato dalla Legge Fornero. Come spero di aver evidenziato, il Jobs Act non è più il provvedimento di rottura che dieci anni fa, sulla scia della Legge Fornero, voleva che la tutela risarcitoria fosse la regola e quella reintegratoria l’eccezione. A seguito di tutta una serie di interventi legislativi e di sentenze della Corte costituzionale, già con il quadro normativo vigente la tutela reintegratoria è tornata a essere la regola.»

(C) RIPRODUZIONE RISERVATA
