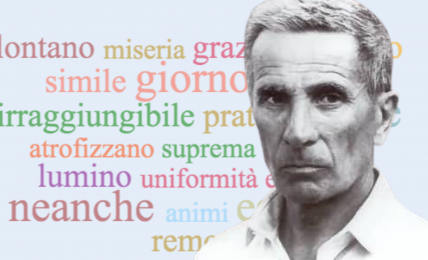“Dare la vita” è queer
L'ultimo e postumo libro di Michela Murgia rilancia la sua visione di cosa sia famiglia, includendo non solo i legami d'anima ma anche la gestazione per altri, che non è estranea alle questioni di classe: "Nessuna dovrebbe essere costretta ad abortire o a partorire perché ha bisogno di soldi".