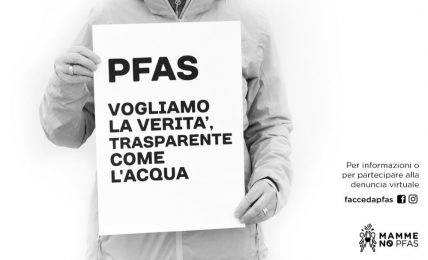Partiti sovranisti, globalizzazione e trilemma di Rodrik: quale futuro per l’Europa
Democrazia, autodeterminazione nazionale e globalizzazione economica sono incompatibili se perseguiti simultaneamente, questo è il cuore del problema europeo, alla base anche della crescita dei partiti sovranisti ed euroscettici.