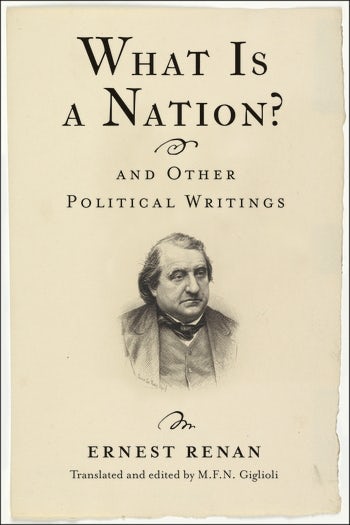Il peccato originale di una Nazione
Il riconoscimento identitario nazionale italiano non è stato costruito su una serie di valori condivisi, bensì con la fidelizzazione allo Stato ottenuta tramite politiche clientelari di redistribuzione della ricchezza e di produzione di debito.