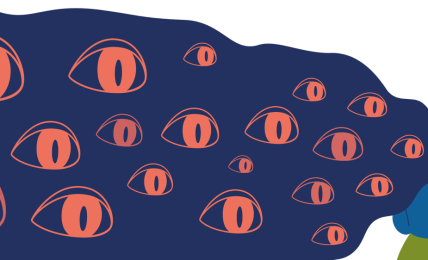Vučko è tornato
Dal 27 febbraio a 2 marzo scorso, le nevi copiose di Bjelasnica hanno ospitato la terza edizione di Telemach Children Speed Camp. Tre giorni di sci con allenamenti in pista, gara finale, e didattica in aula riservati a una sessantina di ragazzi provenienti da diverse nazioni. È stata l'occasione per tornare laddove 39 anni fa si sono tenuto le prime olimpiadi invernali in un Paese comunista. E capire cosa è diventata oggi la Bosnia-Erzegovina.