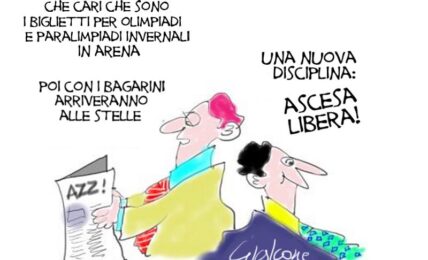Giorno della felicità: non neghiamoci la tristezza
Il 20 marzo di ogni anno viene celebrato il Giorno Mondiale della Felicità. Ma riconoscere l’importanza della felicità e del benessere come obiettivi universali dell’umanità non esclude che, per arrivarci, si debba passare attraverso il riconoscimento delle sensazioni negative.