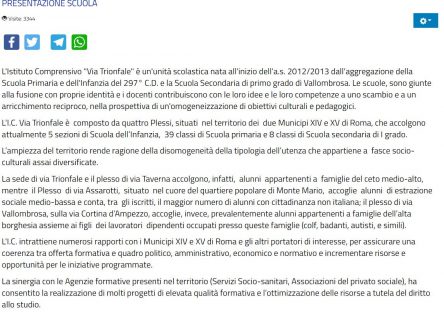La scuola e il classismo, ovvero la fiera dell’ipocrisia
Il caso di un istituto comprensivo di Roma, in cui è stato messo in evidenza che ogni plesso è caratterizzato da un'omogeneità di ceto, ha creato polemiche. Questa storia restituisce un po’ di verità: le classi sociali non sono affatto sparite e sono invece attive e condizionanti.